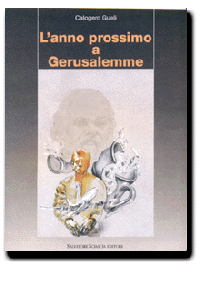L’anno prossimo a Gerusalemme è un libro singolare. In un dialogo immaginario con l’autore potremmo chiedergli: “poteva essere un po’ più semplice?”; lui ti risponderebbe “più di così?”.
Se gli facessimo notare che forse 470 pagine sono un filo eccessivo per un pubblico ormai abituato ai brodini sentimentali, lui replicherebbe candido: “Non c’è una parola di troppo”. E se infine lo guardassimo perplessi e gli dicessimo che non sapremmo collocare quella strana creatura che è l’anno prossimo a Gerusalemme, lui replicherebbe, con una punta di commiserazione, che odia i generi.
Ma poi capisci, leggendolo, che se ne serve a piene mani: c’è l’aspetto storico, la vicenda infatti è ambientata nei difficili anni novanta, nel turbine di quei difficili anni di tangentopoli; c’è il tema del viaggio misto ad una strana ed affascinante fuga: il protagonista, dotato di eccellente intuito filosofico, si sposta spesso da un luogo all’altro descrivendone mirabilmente aspetti ed impressioni; c’è infine quello che si usa chiamare il romanzo di idee: una cascata di riflessioni filosofiche, storiche e politiche che marciano verso il lettore.
L’autore ha dato vita ad uno straordinario affresco psicologico e sociale costruito sui dettagli di una straordinaria cultura e sorretto da un crescendo linguistico che appare unico.