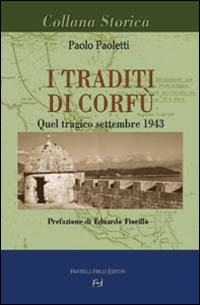Una rilettura storica dei fatti sulla base di nuovi documenti inediti
Con il proclama dell'armistizio dell'8 settembre 1943 i tedeschi si sentirono traditi ma gli Alleati non si fidavano degli ex-nemici. La reazione dei nostri soldati, in particolare quelli sorpresi nei Balcani, fu unanime: chiedere l'imbarco per il ritorno in patria. Ma dopo due giorni di silenzio, gli ordini del Comando Supremo furono di considerare i tedeschi come nemici e di resistere sul luogo. E il col. Lusignani, comandante del 18°reggimento fanteria di stanza a Corfù, non ebbe tentennamenti, diversamente dal suo superiore, il gen. Gandin, a Cefalonia. Corfù respinse il primo tentativo di sbarco tedesco ma dovette cedere sotto il secondo. Il Comando Supremo e l'Aviazione sottovalutarono la situazione critica in cui versò l'isola per una decina di giorni. Gli alleati, che non avevano rispettato gli accordi di Quebec, in cui le Nazioni Unite si impegnavano a sgomberare le truppe italiane nei Balcani, rimasero sorpresi della resistenza dell'isola ed il 20 settembre decisero d'intervenire in soccorso con proprie truppe. Ma la decisione fu tardiva.
Il libro è frutto di ricerche archivistiche presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina Militare, l'archivio militare tedesco di Friburgo e il Public Record Office di Londra. La scoperta di nuovi documenti inediti, soprattutto la relazione del capo della missione militare inglese lanciata sull'isola il 21 settembre, ha imposto una rilettura generale dei fatti. Corfù cadde per una serie di ragioni: perché l'Aviazione italiana non utilizzò l'aeroporto di Corfù, lasciando ai tedeschi il pieno controllo del cielo e del mare, perché l'isola rimase senza rinforzi per 2 settimane e fu vittima del contraddittorio atteggiamento alleato: fino al 17 settembre gli Alleati impedirono l'invio di rinforzi,poi, quando si resero conto che potevano sfruttare la determinazione del presidio italiano per mantenere Corfù in nostre mani, si mossero ma i tedeschi sbarcarono proprio il giorno in cui un generale inglese avrebbe dovuto arrivare per coordinare l'arrivo sull'isola del contingente alleato.Per Hitler anche i soldati di Corfù avrebbero dovuto subire la stessa sorte del presidio di Cefalonia ("nessun prigioniero italiano"), ma il comandante del XXII Corpo d'Armata, gen. Lanz e quelli del comandante della 1adivisione alpina, von Stettner seguirono altre direttive, per cui furono fucilati solo gli ufficiali che si erano opposti con le armi allo sbarco tedesco: in pratica furono passati per le armi “solo” 26 ufficiali.
Prefazione di Eduardo Fiorillo
All’udire Cefalonia, per effetto della mole di lavoro storiografico e delle imprese celebrative, ma ancor più della finzione letteraria e cinematografica che attualizza, romanzandole, le vicissitudini storiche e le rende familiari a un più vasto pubblico, la mente va subito alla divisione Acqui, alla resistenza e all’eccidio dei soldati italiani. La maggiore delle isole ionie è assurta a luogo della memoria. Persino il vacanziere più distratto ben difficilmente mancherà di sostare dinnanzi il monumento ai caduti, presso la Casetta Rossa e la vicina fossa comune. Se appena più volenteroso visiterà di certo la mostra permanente, frutto dell’ impegno di un modesto quanto generoso gruppo di residenti italiani. Corfù al contrario ci parla solo di vacanze in Grecia. Nulla colà, neanche una lapide, rammenta all’ignaro turista le vicende ugualmente drammatiche che coinvolsero i soldati italiani pressoché negli stessi giorni del ’43, susseguenti l’armistizio. Eppure a Corfù si consumò d’un fiato la tragedia, e con essa la beffa, di un gran numero di italiani che pochi giorni prima avevano sperato e creduto che l’incubo della guerra stesse per finire e che sarebbero tornati a casa. Il primo tradimento è dunque quello della memoria.
Questo libro è la storia di una battaglia, non delle più decisive per l’esito della seconda guerra mondiale, durata appena 14 giorni, dal 13 al 26 settembre del ’43. La storia e non la semplice cronistoria, poiché l’autore, al quale va senz’altro il merito di avere riaperto un “fascicolo” che era stato chiuso troppo in fretta, stimolando nel contempo altri a fornire in futuro il loro contributo, non si limita a confrontare le fonti onde ricostruire nel modo più veridico le vicende belliche di quei giorni, ma si pone, con chiarezza quasi didascalica, delle domande, ricerca a quei fatti delle cause, scandaglia con imparzialità i comportamenti dei protagonisti. E la prima domanda, dato che di una battaglia si parla, non può che riguardare le forze in campo, ossia chi ebbe a combatterla. E qui subito appare una prima peculiarità: in una guerra che si stava già perpetrando da tempo tra le forze Alleate e quelle dell’Asse, la battaglia di Corfù è combattuta dalle forze tedesche dei tre corpi contro le sole forze italiane di terra di stanza sull’isola, alleate fino a pochi giorni prima e ora divenute nemiche. Per quale ragione, o piuttosto per quali scopi e in seguito a quali errori di valutazione, i circa 5000 soldati del presidio di Corfù furono dal Comando Supremo italiano e da quello alleato, dapprima impegnati militarmente, anziché rimpatriati, e poi sostanzialmente abbandonati al loro destino? Lungi dal fornire una risposta preconfezionata a questa fondamentale domanda, l’autore, avvalendosi quasi unicamente di fonti di prima mano laboriosamente raccolte (fonogrammi, rapporti e testimonianze provenienti dagli archivi militari italiani, tedeschi ed inglesi), le rende fruibili al lettore trasformandole mirabilmente in un puzzle che quest’ultimo avrà il privilegio di comporre.
E in verità la sensazione che deriva dalla lettura di questo libro, così come del suo analogo dedicato alle più note vicende di Cefalonia (P. Paoletti, I traditi di Cefalonia, Genova 2003) è quella di un profondo coinvolgimento nell’agonia di tanti uomini che in sì breve lasso di tempo videro mutarsi la speranza di rivedere i propri cari nella consapevolezza di essere stati traditi e consegnati nelle mani di chi considerava piuttosto loro dei traditori e di pugno dal proprio Führer aveva ricevuto l’ordine di non fare prigionieri. Una sensazione prodotta non da artifizi retorici, giacché lo stile espositivo di P. Paoletti è improntato all’essenzialità e al rigore storiografico, ma dall’intrinseca vivida drammaticità dei documenti riportati.
In realtà molti dei soldati italiani di Corfù trovarono la morte successivamente alla resa, sotto le bombe alleate. Ultimi in ordine di tempo a pagare lo scotto di un tradimento ancora più grande, quello di chi tre anni prima, da un balcone di Palazzo Venezia, aveva dato il via all’avventura sempre tragica della guerra.
Introduzione
Nel prossimo anniversario che celebrerà i 60 anni dalla strage della “Acqui” a Cefalonia, l’oratore non mancherà di dedicare due parole ai circa 600 tra ufficiali e soldati della stessa divisione caduti a Corfù tra il 13 e il 27 settembre 1943. Ma Cefalonia purtroppo vanta cifre molto più alte e inevitabilmente metterà in secondo piano le povere vittime di Corfù. Siccome la pietà e il ricordo devono andare indistintamente a tutti quelli che combatterono e morirono lontano dal suolo patrio per la stessa causa e con gli stessi ideali, ci siamo sentiti in dovere di fare la stessa ricerca e la stessa rilettura delle vicende del 18° reggimento della divisione “Acqui” a Corfù.
Rispetto ai loro colleghi di Cefalonia, il destino per i soldati dislocati a Corfù fu meno sanguinoso, nel senso che qui non ci furono eccidi di massa indiscriminati, ma la loro sorte fu ugualmente tragica, perché altre centinaia di soldati morirono in combattimento, prima sotto le bombe tedesche e poi sotto quelle alleate, sotto quello che oggi si definisce “fuoco amico”. Per i sopravvissuti ci fu quella prigionia, che alcuni di loro aborrivano più della morte, violenta ma istantanea, sul campo di battaglia.
Un’altra differenza fra i difensori di Corfù e tutti gli altri soldati italiani che vennero colti dall’armistizio all’estero è che i primi si vennero a trovare relativamente vicini alla madrepatria. Ciononostante la storiografia italiana ha sempre avuto un atteggiamento assolutorio verso la mancata difesa delle isole, in particolare di Cefalonia e Corfù, come se fosse stato un destino ineluttabile quello di soccombere sotto gli attacchi tedeschi. Se invece si rileggono le carte si vede che la distanza di Corfù dalle coste pugliesi di circa 120 km minore rispetto a quella di Cefalonia, poteva essere sostanziale ai fini del mantenimento dell’isola in mani italiane. In effetti i 370 km di distanza dalle piste pugliesi facevano di Cefalonia un obiettivo irraggiungibile ai nostri caccia-bombardieri, mentre Corfù rientrava nel raggio d’azione dei nostri aerei e a maggior ragione delle nostre navi. L’isola, più vicina della stessa Sardegna alla terraferma italiana liberata, aveva un grosso neo: era divisa dalle coste greche solo da uno stretto braccio di mare. Nella parte nord l’isola distava dalla terraferma non più di un paio di chilometri, per cui Corfù era una portaerei immobilizzata alla mercè delle artiglierie pesanti tedesche. Ma questo grave handicap poteva essere compensato, se ci fosse stato un fermo impegno nel sostenere la resistenza del presidio di Corfù.
Corfù era un’isola strategica per tutti i contendenti ma per gli italiani lo era in modo particolare: era importante dal punto di vista militare, come punto di appoggio per il rimpatrio dei militari italiani dai Balcani, e politico, in quanto in quei giorni lo Stato e il Governo italiano si volevano accreditare agli occhi alleati come cobelligeranti a tutti gli effetti.
Invece le carte scoperte negli archivi giustificano il rammarico espresso allora dal comandante del presidio, il col. Luigi Lusignani, il quale ebbe a dire prima della sua fucilazione: “Se ci avessero aiutato, avremmo potuto resistere”.
Come per il libro sulla strage di Cefalonia, non ci siamo soffermati sulle fasi militari delle due battaglie, già trattate da storici italiani (Torsiello, Montanari ecc.) e tedeschi (Schreiber, Fricke). Non ci siamo neppure occupati delle relazioni italo-corfiote, già oggetto degli studi del metropolita di Corfù e Paxos, Methodius¹ e di Kostas Dafnis². Abbiamo, invece, cercato di riflettere sul comportamento dei due comandanti, il gen. Gandin a Cefalonia e il col. Lusignani a Corfù, e sugli aspetti storici delle due vicende.
Uno dei motivi che ci hanno spinto a scrivere un libro sul settembre 1943 a Corfù è stato anche il fatto che i documenti ci hanno svelato che la resistenza italiana a Corfù divenne effettivamente disperata per il mancato rispetto degli accordi da parte degli Alleati e per gli errori strategici e tattici del Comando Supremo e dell’Aviazione italiana. Le novità di questa ricerca provengono per lo più da documenti inediti: gli allegati del Diario Storico del Comando Supremo (da qui in avanti DSCS), le testimonianze dei reduci conservate all’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e a quello della Marina, gli atti del processo di Norimberga contro il gen. Lanz e il rapporto ufficiale della missione militare inglese “Acheron”, che arrivò a Corfù il 21 settembre 1943.
Le novità che emergono da questa documentazione riguardano vari temi. Una di queste è stata proprio la scoperta delle tardive ma reali intenzioni alleate di fare di Corfù la Lero dell’Adriatico, un’isola dove gli italiani avevano il totale controllo del territorio, godevano delle simpatie della popolazione, potevano mettere a disposizione degli Alleati porti e un aeroporto per lo sbarco dei rinforzi. L’intelligence del col. Lusignani, verosimilmente grazie alle notizie fornite dai partigiani greci, aveva preventivamente indicato gli obiettivi da colpire, aveva persino previsto i tempi e il luogo del secondo sbarco tedesco. L’isola poteva dunque essere mantenuta in nostro possesso ma purtroppo mancò completamente il supporto aereo e, nonostante l’impegno profuso dalla Marina, anche quello navale italiano. Il contrattacco tedesco a Salerno aveva avuto il suo culmine il 13 settembre 1943, giorno del primo fallito tentativo di sbarco a Corfù. Se il 20 settembre Eisenhower, allora Comandante in capo Alleato nel Mediterraneo, ordinò alla missione militare britannica “Acheron” di paracadutarsi su Corfù, è perché credeva di aver ancora tempo per salvare l’isola. Quando gli Alleati si resero conto che la resistenza dell’isola offriva quei requisiti minimali per tentare un loro appoggio concreto e che il rapporto rischio-benefici era diventato accettabile, decisero di intervenire, anche se Corfù non rientrava nei piani delle isole, ove inviare un contingente alleato a supporto di quello italiano. Ma quando Eisenhower decise di imporre agli inglesi di dare il supporto alleato per tenere l’isola, era diventato troppo tardi e noi pagammo per la loro incertezza iniziale. Ma Corfù anche se avesse resistito al secondo tentativo di sbarco tedesco, non avrebbe potuto rimanere in mani italiane senza un costante aiuto alleato.
Risulta invece confermato che Corfù fu un fulgido esempio di dedizione alla patria, compiuta in piena sintonia tra ufficiali, soldati italiani e partigiani e popolazione greca. La ‘riconoscenza’ dell’Italia si manifestò sin dal 1948 con due sole medaglie d’oro alla memoria e una alla bandiera del reggimento.
Le irriverenti parole di Attilio Tamaro, che scriveva³: “La resistenza fu impresa disperata ed inutile e in un certo senso anche profondamente ingiusta, perché fatta solo per sentimento di onore, senza forze, senza possibilità di aiuti, alla ventura di Dio e portò alla completa rovina della città e dell’isola, con infinito danno di quei poveri greci, ai quali avevamo, dopo tante sventure loro inferte, il dovere di donare la pace e la sicurezza. Invece i nostri vollero far partecipare all’impresa anche i partigiani di Papas Spiro, perseguitato da noi fino alla vigilia”. Attilio Tamaro avrebbe dunque preferito per Corfù la resa italiana e l’occupazione nazista, senza capire che i partigiani greci avevano scelto, anche se come male minore, la nostra presenza a quella germanica. Che la guerra sia sempre la peggiore delle soluzioni è noto, così pure che in guerra spesso si combatte ad armi impari; altre volte certe imprese sono disperate fin dall’inizio ma a volte lo diventano per ragioni estranee a chi le compie. Tamaro non considerava inoltre che occorreva difendere Corfù anche per salvare le decine di migliaia di militari sbandati che si accalcavano nei porti albanesi. Solo la mancanza di strategia del Comando Supremo e dell’aviazione italiana furono i principali responsabili del fatto che l’isola cadde proprio quando gli Alleati si erano convinti a difenderla.
Autore: Paolo Paoletti
Editore: Fratelli Frilli
Pagine: 170